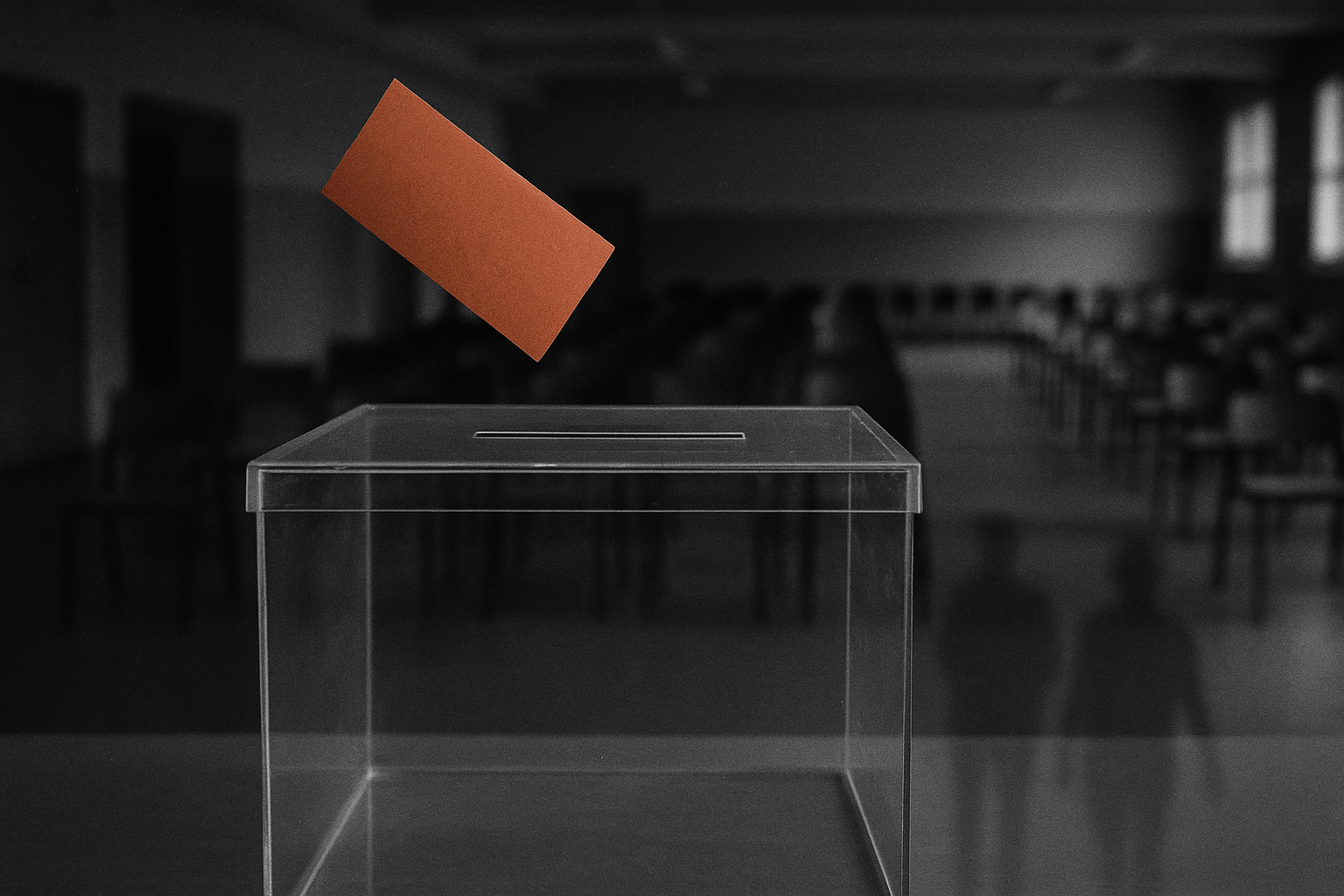Nell’autunno del 2022, alle politiche, ha votato il 63,9% degli italiani. È stata la partecipazione più bassa della storia repubblicana, quasi nove punti in meno rispetto al 2018, secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno. Due anni dopo, alle europee del giugno 2024, la discesa è proseguita: per la prima volta il Paese è sceso sotto il 50%, con un’affluenza del 48,3%.
Nelle regionali, la forbice si allarga ancora: in Lazio ha votato appena il 37%, in Lombardia il 42%, in Calabria il 43%, in Emilia-Romagna e Liguria il 46%. È un fenomeno strutturale, non episodico. Il documento “Perché gli italiani non votano più”, presentato nel 2025 da un gruppo di ricercatori e amministratori, mostra come il crollo non riguardi solo la frequenza alle urne, ma il senso stesso del voto. In molte aree, soprattutto nel Sud, la partecipazione reale è ancora più bassa di quanto appaia: l’Istat e lo stesso Viminale segnalano che in alcune regioni un quinto degli iscritti alle liste è residente all’estero (Aire), e dunque non partecipa di fatto al voto locale.
Secondo l’ultimo sondaggio Censis-Coldiretti (ottobre 2025), sette italiani su dieci si dichiarano “distanti” dalle istituzioni europee e nazionali, e il 76% boccia l’idea di sacrificare welfare e agricoltura per aumentare la spesa militare. È la fotografia di una disillusione politica che non nasce da indifferenza, ma da una convinzione opposta: che la politica non risponda più ai bisogni sociali reali.
Astensionismo, il voto che non serve più
Gli studiosi chiamano questo sentimento “bassa efficacia politica percepita”. L’European Social Survey 2024, che monitora la fiducia civica in ventinove Paesi, colloca l’Italia ai livelli più bassi in Europa per convinzione che “il proprio voto conti qualcosa”. È un segnale di disincanto, non di apatia. Dopo vent’anni di stagnazione economica, salari fermi e precarietà, molti cittadini non credono più che le elezioni possano modificare la loro condizione materiale.
Il sociologo Ilvo Diamanti, in una lezione all’Università di Urbino, ha sintetizzato il paradosso: «L’astensione è la nuova forma di partecipazione. Serve a dire che non ci si riconosce più nel sistema». L’analisi dei flussi elettorali conferma che l’astensionismo non è distribuito in modo uniforme: cresce tra i giovani, tra i redditi medio-bassi e nelle periferie urbane, dove la distanza dai centri decisionali è percepita come irrimediabile.
Una parte del problema è anche numerica. Come ha spiegato l’analista Lorenzo Ruffino «la partecipazione non è crollata ovunque nello stesso modo: le regioni più ricche e istruite mantengono livelli più alti, mentre il Sud si svuota delle sue urne». Ruffino ricorda che «il voto fuori sede, la mobilità giovanile e l’assenza di partiti radicati localmente» pesano più della semplice sfiducia, e che «la frattura territoriale dell’affluenza è ormai un indice del divario sociale».
A pesare sono anche gli ostacoli pratici. L’Italia resta tra i pochi Paesi europei a non prevedere il voto fuori sede: uno studente o un lavoratore che si trovi lontano dal comune di residenza deve tornare indietro, spesso per centinaia di chilometri. Alle europee 2024 il Ministero dell’Interno ha sperimentato il voto fuori sede per circa 23 mila studenti, ma la misura non è stata estesa ad altre categorie.
Le riforme che non bastano
Nel dibattito politico si parla di “voto comodo”: per corrispondenza, anticipato, digitale. Esperienze già collaudate in altri Paesi. Negli Stati Uniti, la possibilità di votare per posta o in anticipo ha aumentato l’affluenza in modo selettivo, soprattutto tra i cittadini con disabilità o impegni lavorativi. In Germania e in Svizzera, il voto postale è ormai parte stabile del sistema. L’Estonia, pioniera del voto elettronico, ha dimostrato che la tecnologia riduce gli ostacoli logistici ma non risolve la sfiducia politica: chi non crede nel valore del voto non lo esercita neanche online.
Lo studio “Perché gli italiani non votano più” propone di partire dalle barriere più immediate: semplificare le procedure, garantire più sedi e orari estesi, migliorare il trasporto pubblico per gli elettori anziani o con disabilità. La proposta di legge sul voto fuori sede, depositata alla Camera nel 2025 dal comitato “Voglio votare fuorisede”, è sostenuta da oltre cento associazioni. Ma finora il governo non ha dato segnali di apertura.
Resta il nodo centrale: il voto è percepito come un gesto senza conseguenze. Le ricerche del Censis e dell’ISTAT mostrano un legame diretto tra fiducia istituzionale e partecipazione politica: dove la fiducia scende, cala anche l’affluenza. L’Italia, nel 2025, è agli ultimi posti in Europa per fiducia nei partiti (13%) e nel Parlamento (18%), secondo Eurobarometro.
La democrazia intermittente
In questo scenario, la disaffezione rischia di diventare cronica. I giovani, come rileva l’indagine “Gen Z e politica” della Fondazione Bruno Visentini, partecipano più attivamente ai movimenti civici e ambientali che ai partiti. È un’altra forma di politica, meno istituzionale, ma non per forza più debole.
L’astensione, dicono i ricercatori, non è più solo un problema numerico: è un segnale di frattura democratica. E se la partecipazione torna a crescere solo quando “c’è una posta in gioco” — come nel referendum costituzionale del 2016 o nelle comunali più polarizzate — significa che il voto è diventato episodico, non strutturale.
Le soluzioni tecniche possono ridurre la fatica del voto, ma non possono restituire fiducia. L’astensione italiana, oggi, è il prodotto di un sistema politico che chiede consenso senza rappresentanza, delega senza ascolto, e che misura la democrazia in percentuali sempre più basse.
Il rischio è di abituarsi a una “democrazia intermittente”, in cui votare diventa un atto occasionale e reversibile, come un abbonamento disdetto. E allora la domanda non è più perché gli italiani non votano, ma perché la politica non parla più agli italiani.