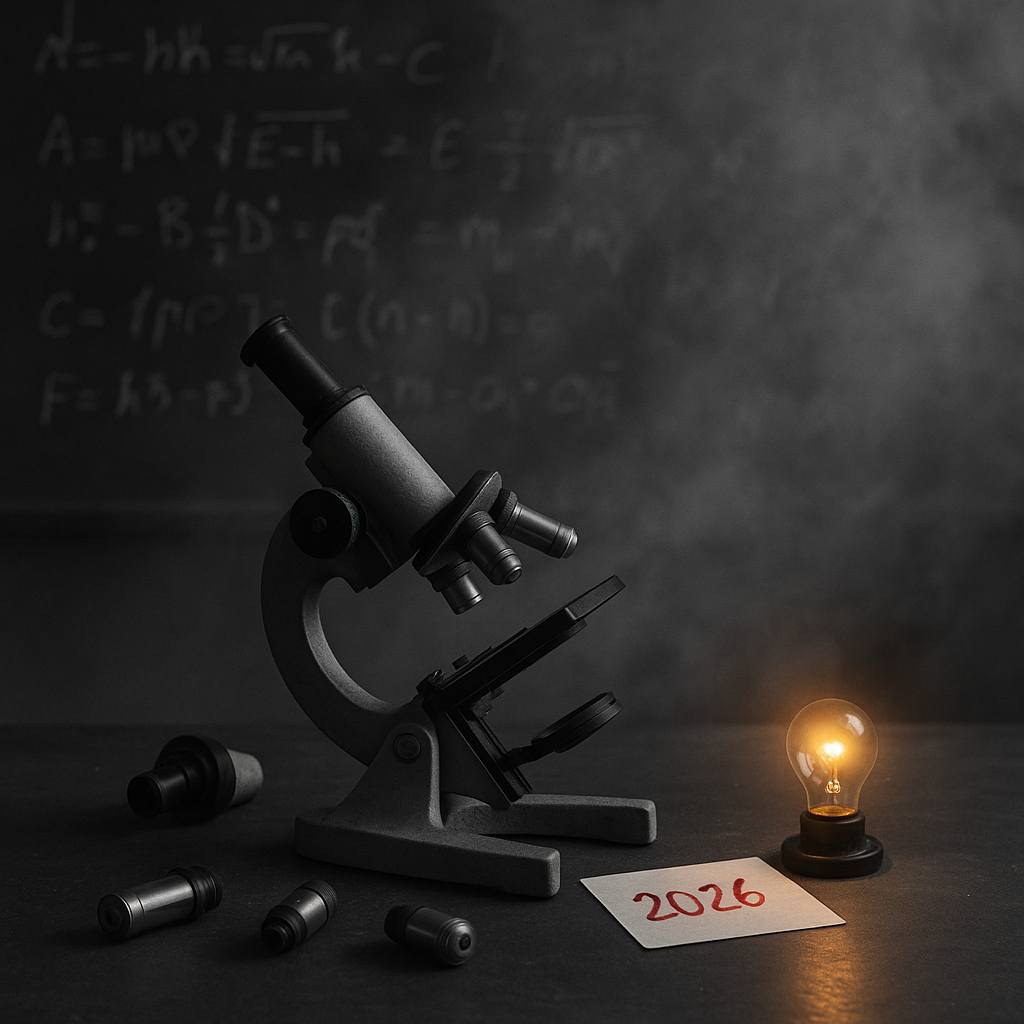Roma, 11 novembre. In piazza Montecitorio la ricerca italiana ha alzato la voce. Dottorandi, post-doc, assegnisti e tecnologi hanno sfilato per chiedere quello che in un Paese normale non si chiede: un futuro. Secondo l’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca, l’86,5 % degli incarichi oggi attivi scadrà entro luglio 2026. Senza un piano di reclutamento, “nove su dieci” usciranno dall’università nell’arco di un anno. Una soglia che non riguarda solo la condizione individuale ma la tenuta stessa del sistema: corsi, laboratori e progetti europei già ora dipendono dal lavoro di chi non ha garanzie.
Una precarietà diventata metodo
Negli ultimi dieci anni i ricercatori precari sono cresciuti di otto volte. Nel 2023 la quota di personale di ricerca a tempo determinato ha raggiunto il 77 %, mentre nel 2013 era sotto il 10%. I contratti durano in media meno di dodici mesi e il 43 % di quelli finanziati con fondi Prin o Pon non arriva all’anno. Retribuzioni medie sotto i 1.700 euro e carriere bloccate spingono verso l’estero intere generazioni di studiosi. Rimangono in Italia circa 30 mila post-doc e 40 mila dottorandi, molti dei quali coprono lezioni e attività strutturali senza tutele piene. È una normalità piegata alla logica dell’emergenza: la ricerca vive, ma sopravvive chi la fa.
Il paradosso è che si parla di “merito” e “eccellenza” in un sistema che alimenta l’insicurezza come condizione strutturale. Ogni anno il Paese forma ricercatori che altri Paesi assumono: Germania, Francia e Spagna attraggono profili italiani con salari più alti del 40% e percorsi di carriera certi. L’Italia resta in fondo alla classifica europea per retribuzioni iniziali e investimenti in ricerca pubblica, fermi all’1,5% del Pil. È il divario che svuota le università mentre la retorica governativa parla di competitività.
FFO insufficiente e “cliff” PNRR
Il governo rivendica un Fondo di Finanziamento Ordinario 2025 pari a 9,4 miliardi, con +336 milioni rispetto all’anno precedente. Un aumento che, nei conti degli atenei, non basta a colmare i tagli pluriennali e l’inflazione: il sottofinanziamento stimato supera il mezzo miliardo. A questo si aggiunge la scadenza dei fondi straordinari del Pnrr, che entro il 2026 termineranno lasciando scoperti migliaia di contratti. È il cosiddetto “effetto cliff”: un salto nel vuoto per i ricercatori assunti grazie alle risorse straordinarie e per i progetti che senza personale non potranno proseguire. L’Adi parla di una crisi funzionale imminente, fatta di corsi soppressi, laboratori chiusi e ricerca competitiva in caduta libera.
Le richieste e la politica distratta
In piazza le parole d’ordine sono nette: coperture certe per i nuovi percorsi di tenure-track, stabilizzazioni per chi svolge mansioni continuative, stop all’abuso degli assegni di ricerca per ruoli permanenti. La ministra dell’Università Anna Maria Bernini rivendica l’aumento dei fondi e promette nuovi strumenti di reclutamento, ma sindacati e associazioni parlano di annunci “senza copertura”. Nel solo Consiglio nazionale delle ricerche, circa 4 mila lavoratori restano precari: di questi, almeno 1.500 avrebbero diritto alla stabilizzazione ai sensi della legge Madia. La deputata dem Rachele Scarpa e la capogruppo Avs Elisabetta Piccolotti avvertono che, senza fondi nella manovra, l’Italia sprecherà i risultati del Pnrr e perderà capitale umano formato con risorse pubbliche.
La manifestazione di Roma non è un episodio, ma un sintomo. Il sistema universitario italiano si regge su una forza lavoro precaria che il bilancio pubblico non intende stabilizzare. Entro un anno migliaia di ricercatori resteranno senza contratto, con finanziamenti ordinari insufficienti e fondi straordinari in esaurimento. Se nulla cambia, l’università pubblica entrerà in modalità emergenza: meno docenti, meno ricerca, meno futuro. E la “culla della conoscenza” rischierà di diventare un cimitero di promesse e di intelligenze lasciate a scadenza.