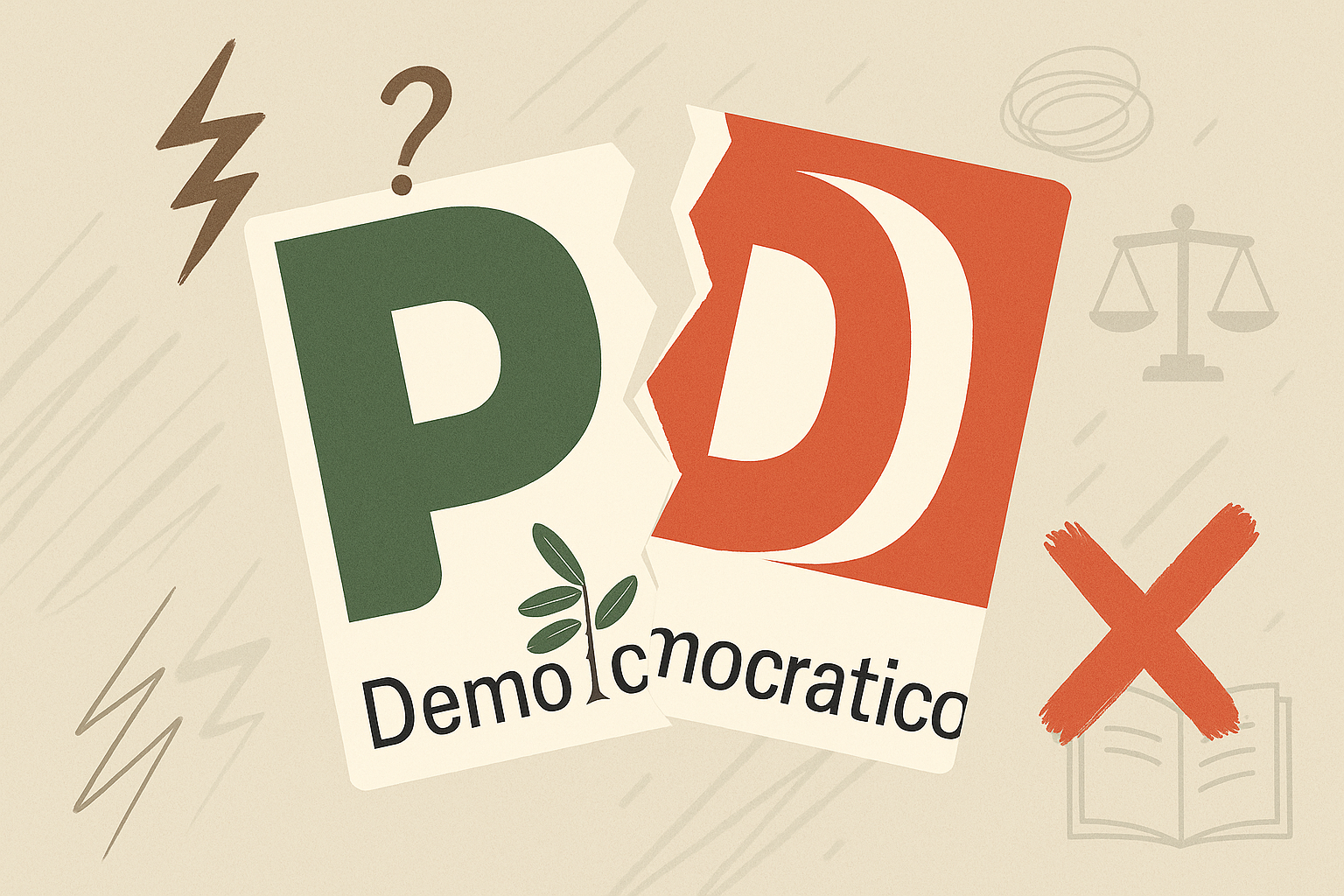C’è chi almeno ha la coerenza del proprio ruolo istituzionale e chi, invece, la smarrisce dietro il calcolo elettorale. L’astensione è diventata la nuova lingua franca di una parte politica: l’ha lanciata Ignazio La Russa con la solita irruenza da tribuno, l’hanno fatta propria alcuni dirigenti del Partito democratico con la compostezza dei sabotatori silenziosi. E non è un caso che l’eco delle loro parole sia indistinguibile da quelle di Matteo Renzi, perfino nella retorica del “paleolitico”.
La linea ufficiale del Pd, sotto la guida di Elly Schlein, è per il sì ai referendum del prossimo 8 e 9 giugno. È una scelta netta, magari anche divisiva, ma almeno chiara. Ma alcuni riformisti, tra cui Lorenzo Guerini, Giorgio Gori, Marianna Madia, Lia Quartapelle, Filippo Sensi e Pina Picierno, hanno firmato una lettera a Repubblica per comunicare che voteranno solo su due quesiti (cittadinanza e responsabilità delle imprese appaltanti) e si asterranno sugli altri tre. Perfino Renzi ha dato indicazione per il voto. Perfino Carlo Calenda. Loro? Astenersi. Neanche un no. Neanche la responsabilità di metterci la faccia con un’opinione diversa. Semplicemente: non votare. Proprio come Fratelli d’Italia, proprio come La Russa.
La grammatica dell’ambiguità del Pd
Il Jobs Act, scrivono, è stato l’ultimo “provvedimento organico sul lavoro”, ispirato alle “migliori esperienze giuslavoristiche delle socialdemocrazie europee”. Il Jobs Act, replicano con le stesse parole Renzi e Calenda, è un’eredità da difendere, e quindi non si tocca. Ma qui non si discute solo di merito: la questione è politica, anzi etica. Un gruppo dirigente che in pubblico si professa democratico e progressista, ma nei fatti rifiuta il confronto popolare su uno dei provvedimenti più contestati degli ultimi dieci anni, sceglie deliberatamente di depotenziare lo strumento referendario. E lo fa proprio quando la segretaria del partito cerca di usare il referendum per segnare un’identità.
Non si tratta di ingenuità. I firmatari della lettera parlano di “simulacro fuori tempo”, definiscono il referendum uno strumento inadeguato e rivendicano che “la condizione del lavoro in Italia passa dal futuro, non da una sterile resa dei conti col passato”. È la stessa narrazione di Renzi, che a Bruxelles ha definito il quesito sul Jobs Act un “passo indietro al paleolitico”, sostenendo che il vero tema dovrebbe essere “stipendi e bollette”. Peccato che a disintegrare stipendi e bollette abbiano contribuito quelle politiche che ora si difendono come conquiste.
Un dissenso organizzato
Lo strappo non è un inciampo ma una frattura consapevole. E arriva dopo settimane di preparazione, come dimostrano le manovre interne al partito con l’organizzazione di un nuovo circolo e l’obiettivo dichiarato di logorare Schlein dall’interno. Perché l’astensione, oggi, è un’arma. E come ogni arma, ha un bersaglio. Il bersaglio è Schlein e la sua linea, colpevole di essersi allineata alla Cgil di Maurizio Landini e di voler riportare il Pd su una traiettoria più vicina alla sinistra sociale.
È uno schema che si ripete. Anche nel 2003, nel referendum sull’articolo 18, una parte del centrosinistra si sfilò con la stessa scusa dell’inutilità del voto. Anche allora si scelse l’astensione come scorciatoia, con lo stesso effetto: smobilitare l’elettorato. L’unica vera conseguenza fu rendere più fragile il fronte del lavoro. E oggi, vent’anni dopo, si ripete lo stesso copione con gli stessi attori.
Chi oggi si rifiuta di votare, chi invita all’astensione per calcoli interni, non sta sfidando Schlein: sta disarmando la democrazia. La differenza, rispetto a La Russa, è solo nei toni. Ma almeno La Russa non finge di essere altro da sé.