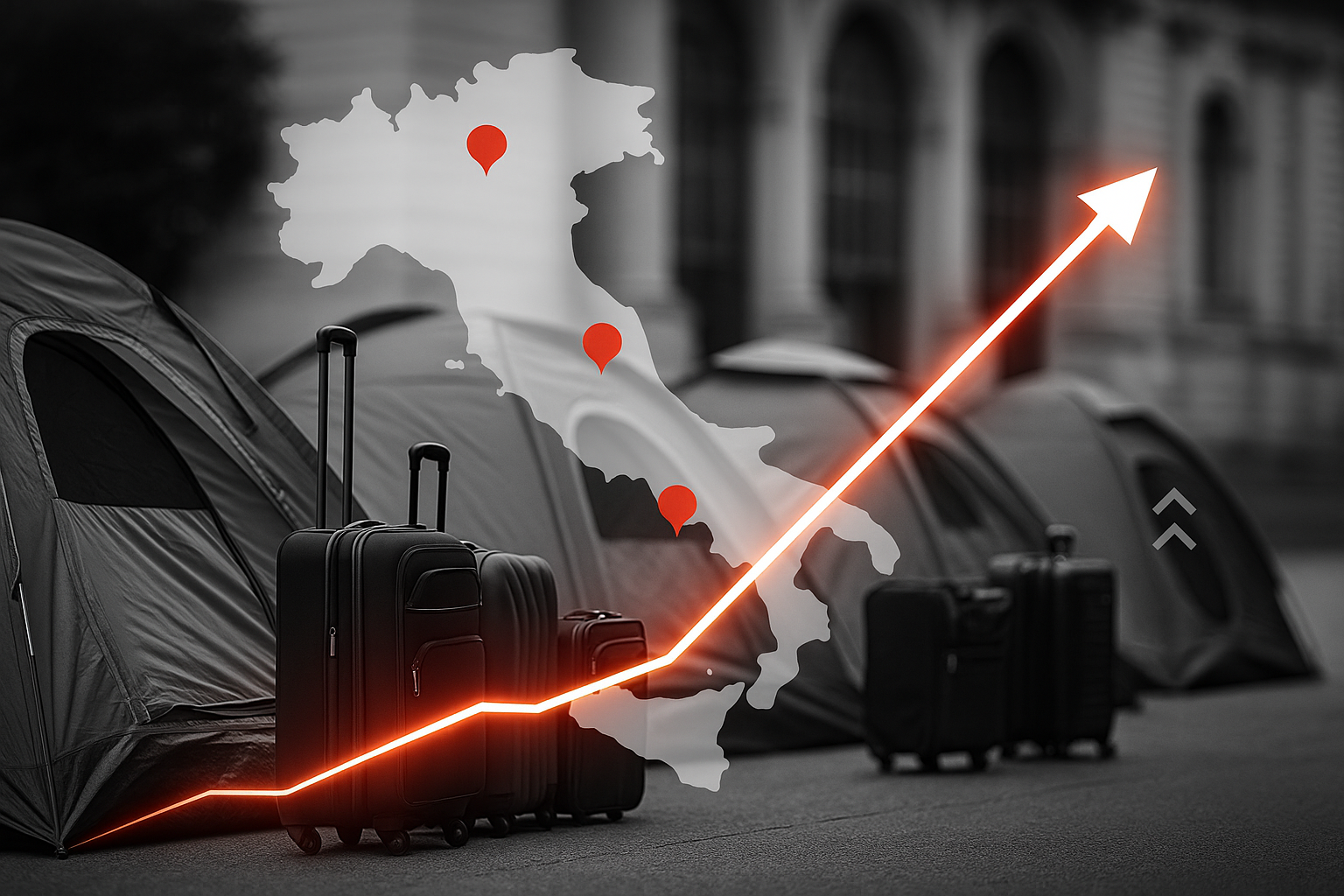La mappa aggiornata racconta un’emergenza strutturale: Milano è la città più cara (732 euro in media per una singola), seguono Bologna (632), Firenze (606), Roma (575). In dodici mesi il prezzo medio nazionale è passato da 461 a 613 euro: +152 euro. È l’istantanea che conferma la denuncia degli studenti: l’università fuori sede si paga come un lusso, in aperto contrasto con l’idea stessa di diritto allo studio. In controluce c’è un paradosso: in diverse piazze la domanda rallenta, ma i canoni continuano a salire. Torino registra un –3% di richieste, Firenze –6%, Milano –13%, Verona –20%, con cali più netti a Bologna e Napoli; nonostante ciò, le tariffe non arretrano. L’aumento non è uniforme: Trento segna il picco (+42,78%), poi Modena (+31,43%) e Brescia (+30%), con studenti che parlano di condizioni «insostenibili».
Questo scarto tra mercato e bisogni sociali è il risultato di un’offerta cronicamente insufficiente di posti pubblici e di un settore privato che, privo di vincoli reali, fissa il prezzo. La serie storica dei dati e le analisi convergono: la pressione sui fuori sede resta altissima e i rincari hanno eroso ogni margine per le famiglie a reddito medio-basso.
Dalle tende alle promesse
La sequenza è nota. Primavera 2023: le tende davanti agli atenei costringono il governo a una reazione. La ministra Anna Maria Bernini annuncia censimenti degli immobili inutilizzati, fondi per alloggi e borse, l’impegno-bandiera di 60mila nuovi posti letto entro giugno 2026. Si parla di «svolta», «pagina voltata», «sfida ambiziosa». Nel 2024 arriva il cosiddetto “pacchetto housing”: 1,2 miliardi, semplificazioni urbanistiche, il commissario straordinario per accelerare i cantieri. A ruota, il racconto di «8.500 posti in più» e dell’«individuazione degli immobili per altri 60mila». Ma i numeri, quando verificabili, non reggono l’enfasi.
A primavera 2025 i report studenteschi e le inchieste mostrano che i posti effettivamente finanziati sono poco più di 11.600, con una prevalenza schiacciante di gestioni private ed ecclesiastiche e una distribuzione incoerente rispetto ai fabbisogni reali delle città universitarie. L’obiettivo Pnrr è lontanissimo e l’impatto sui canoni inesistente. Nel frattempo, i sostegni diretti restano residuali: il Fondo affitti per i fuori sede è rifinanziato ma, tra ritardi e importi medi nell’ordine di poche centinaia di euro l’anno, raggiunge una quota minima della platea e non sposta i prezzi.
Pnrr, obiettivi mancati e mercato drogato
L’architettura scelta dal ministero ha privilegiato un meccanismo di contribuzione ai costi di gestione per i primi anni, non la costruzione o la ristrutturazione profonda. Con una dote attorno a 20mila euro a posto, il modello ha favorito i soggetti già capitalizzati (fondi immobiliari, grandi operatori, enti ecclesiastici) e tagliato fuori, di fatto, gli enti pubblici per il diritto allo studio. Risultato: il 98% dei posti finanziati va a privati, la copertura pubblica cresce impercettibilmente e i canoni non si calmierano.
Il caso Modena è emblematico: l’apertura di uno studentato a tariffa “calmierata” intorno ai 550 euro ha spostato il riferimento del mercato verso l’alto, alimentando rincari anche nel privato diffuso. È la dinamica che gli studenti definiscono «drogare il mercato». La clausola sociale (sconti minimi rispetto ai valori di zona, una quota riservata agli idonei) non basta se i valori di zona sono già fuori portata, e se la destinazione d’uso “studentato” è limitata nel tempo, con il rischio di restituzione al mercato ordinario una volta scaduti i vincoli.
Sul fronte dei tempi, l’asimmetria è evidente: anche ammettendo procedure veloci, nessun cantiere incide sui canoni dell’anno accademico in corso; nel frattempo, decine di migliaia di studenti si contendono il poco disponibile nelle settimane decisive per l’immatricolazione. L’effetto leva pubblico, così impostato, non ha calmierato i prezzi; li ha, semmai, consolidati.
Dentro questa impasse pesano anche fattori cittadini: la crescita degli affitti brevi, la rendita turistica, regolazioni locali inadeguate, una pianificazione dell’edilizia studentesca che in alcuni casi ha ignorato proprio i poli con maggiore pressione. Il risultato è una geografia degli interventi “a macchia”, con intere aree universitarie sostanzialmente escluse dai nuovi posti.
Il conto sociale e politico
L’escalation dei canoni sta ridefinendo l’università come selezione economica. La copertura pubblica dei posti letto resta marginale a fronte di una platea stimata tra 800 e 900mila fuori sede; il resto è affidato al mercato. «Frequentare fuori casa è un lusso per pochi», ripete l’Udu, e i numeri lo confermano. La scelta di spingere sulla leva privata, senza un ancoraggio nazionale ai canoni e senza un piano pluriennale di residenze pubbliche, ha prodotto l’effetto opposto a quello dichiarato: più risorse mobilitate, ma zero impatto sui prezzi entro le scadenze del Pnrr.
Il governo ha preferito il linguaggio delle «svolte» alla fatica di una politica industriale dell’abitare: acquisizioni e riuso di patrimonio pubblico, programmazione stabile di Ersu/Edisu, vincoli reali sugli affitti brevi nelle aree universitarie, sostegni diretti tempestivi e capienti. Mentre la retorica del merito si consuma, migliaia di matricole valutano se rinunciare, fare pendolarismo estremo o ripiegare su soluzioni lontane dai campus. È un danno misurabile in abbandoni, ritardi, occasioni perdute: una tassa occulta sul futuro.
La fotografia di oggi non è un incidente di percorso, è il segno di una direzione politica. Il prezzo lo pagano gli studenti e, con loro, le città che perdono vitalità e competenze. Finché il diritto all’alloggio rimarrà un sottocapitolo dell’urbanistica privata, ogni annuncio si sbriciolerà alla prova del mercato. I dati di agosto lo dicono senza retorica: più 152 euro non sono un titolo, sono una resa.